UMBERTO GALIMBERTI : SCHOPENHAUER E IL PESSIMISMO
Arthur Schopenhauer nasce a Danzica il 22 febbraio del 1788.
La giovinezza di Schopenhauer è segnata da numerosi viaggi in giro per
l’Europa. Il padre, commerciante, li vede come un valido strumento di
preparazione alla stessa professione. Ma in seguito alla morte del genitore,
Arthur si allontana dall’ambiente mercantile per dedicarsi agli studi
umanistici. Sua madre, scrittrice,
si trasferisce a Weimar, dove dà vita a un salotto letterario frequentato anche
da Goethe. Il giovane Schopenhauer conosce così il padre della letteratura
tedesca. Schopenhauer cominciò successivamente a insegnare all’Università di
Berlino, la stessa in cui insegnava anche Hegel, egli non ottenne molto
successo con i suoi corsi, poiché li programmava allo stesso orario delle
lezioni di Hegel, quindi tutti andavano alle lezioni di Hegel e nessuno alle
sue.
Schopenhauer si definiva un filosofo inattuale rispetto al
suo tempo, questo suo pensiero si può collegare sia a Nietzsche sia a Freud, questo può essere collegato ala sua triste
biografia o alla sfortuna delle sue opere, come per esempio la sua opera più
importante ossia il mondo come volontà e rappresentazione che ricevette una
critica pessima a causa del suo carattere pessimistico e anti-idealistico.
Grazie alla raccolta di saggi Parerga e paralipomena, in cui riprende i temi dell’opera il mondo come volontà e
rappresentazione ma li espone in modo brillante, con anche degli aforismi
pungenti e con delle riflessioni particolarmente significative.
Il pensiero Schopenhaueriano si fonda sul fatto che il nostro
io non è colui che governa la nostra esistenza, ma noi siamo governati da una
volontà irrazionale che è la forza la potenza della natura che ci vede
esclusivamente come funzionari per la sua autoconservazione. In noi ci dovrebbe
essere una doppia soggettività:
·
una illusoria creata dal nostro io, ma questo è un mondo di inganni di
illusioni,
·
mentre il vero regista della
nostra vita è la specie che ci vede semplicemente come funzionari per la
sua autoconservazione.
Noi viviamo in un mondo di rappresentazione che nacque con
Cartesio, ossia quello che noi conosciamo è semplicemente la rappresentazione
che la nostra mente si fa del mondo. L’essere per Schopenhauer perché ritiene
che la natura sia sostanzialmente un eterno e inarrestabile divenire.
Con Cartesio nasce il mondo come rappresentazione, egli
infatti ritiene che noi non conosciamo la natura, ma conosciamo solo le
risposte che la natura da alle nostre ipotesi. Nasce in questo periodo anche il
metodo scientifico dalla scienza cosiddetta moderna, in passato si osservava la
natura al solo scopo di individuarne le costanti, mentre attraverso il metodo
scientifico si suppone che la natura ha delle prove cosiddette sperimentali e
che se vengono soddisfatte le ipotesi esse divengono leggi di natura. Cartesio
sostiene che l’uomo attraverso la scienza diventa dominatore e padrone del
mondo. Secondo il filosofo noi conosciamo il corpo se lo guardiamo non per come
lo sentiamo a partire dal mondo e dalla vita, ma se lo conosciamo attraverso idee
chiare e distinte, come per esempio le idee della fisica, facendo nascere così
il copro medico.
Il mondo come rappresentazione viene spiegato attraverso i
quattro principi della ragion sufficiente: dell’essere nel quale noi
collochiamo tutti gli enti nello spazio e nel tempo nella loro successione
causale, grazie alle quali noi li conosciamo. Del divenire attraverso cui noi
interpretiamo tutto ciò che diviene sulla base del principio della cause e
dell’effetto. Del conoscere per cui noi assumiamo come vere le conclusioni
giustificate da premesse. Dell’agire per cui giustifichiamo le nostre azioni a
partire dalle motivazioni. Tutto questo secondo Schopenhauer è rappresentazione
del mondo, è giustificazione che l’uomo introduce per nobilitare sé stesso e non
vedersi semplicemente per quello che è in verità, ossia semplice funzionario
della specie.
Kant riconosce la grande rivoluzione operata da Cartesio,
ossia che quello che noi conosciamo non è la realtà in sé ma è la sua
rappresentazione, concludendo dice che noi non conosciamo la cosa in sé, detto
noumeno, ma conosciamo le cose per come ci appaiono, ossia i fenomeni.
Schopenhauer si oppone all’affermazione fatta da Hegel, ossia
tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è razionale è reale, poiché ritiene
che il mondo sia regolato no dalla rappresentazione ma dalla volontà.
Sia la filosofia antica, sia la filosofia contemporanea, sono
caratterizzate dall’esclusione dalla corporeità. Già Cartesio aveva stabilito
che il corpo è la prigione dell’anima, perché riteneva che le informazioni
sensibili che ci provengono attraverso il corpo non sono attendibili a
costruire un sapere oggettivo e universale. Non possiamo affidarci al corpo
cosi come lo sentiamo e lo percepiamo nel mondo della vita. Schopenhauer ritiene
che il corpo sia il luogo in cui si manifesta quella forza che la natura
esprime sia nel mondo inorganico,vegetale, animale e umano.
Il bisogno e il desiderio sono due figure della mancanza,
cioè io desidero quello che non ho, questo motivo era già stato anticipato da
Platone, egli percepisce l’amore come un bisogno e una mancanza. Dai desideri soddisfatto nascono altri
desideri che se non nascono naturalmente vengono creati. In seguito, Schopenhauer
sostiene che la soddisfazione non va ad estinguere il desiderio, bensì ne crea
altri, che creano una catena di bisogni, cioè una catena di mancanze, che
costituiscono la condizione del dolore umano, ma la sua assenza porterebbe alla
noia.
La vera macchina è la macchina della forza della specie che
inganna gli uomini con l’appetito sessuale e questi corrotti dal desiderio
sessuale generano non per se ma per la specie, che senza generazione si
estinguerebbe.
Schopenhauer si collega alle filosofie orientali, che sono
filosofie di accettazione di ciò che accade, la non volontà è l’atteggiamento
che noi dobbiamo assumere per contrastare la volontà irrazionale e le strade
per farlo sono indicate da Schopenhauer in tre figure:
1. la compassione: la
consapevolezza che il dolore non è individuale ma appartiene a tutta quanta la
specie, utilizzata dalla natura per la sua economia e non per l’economia dei
singoli individui
2. l’arte: ci porta fuori
dallo spazio, dal tempo, dall’interesse, dal desiderio
3. l’ascesa: l’astinenza
sessuale, poiché se non si procreasse anche la volontà irrazionale che promuove
la natura in tutte le sue creazioni si estinguerebbe
La scena politica
internazionale del’800 è dominata dalla figura di Napoleone che al comando
delle armate francesi intraprende una lunga serie di campagne militari in
Europa, La sua politica aggressiva provoca la reazione dei paesi che vedono
minacciata la propria integrità territoriale e nazionale. La coalizzazione tra
Russia, Prussia, Inghilterra e Austria riuscirà a porre fine all’avanzata di
Bonaparte con la battaglia di Waterloo nel 1815. Le potenze vincitrici si
riuniscono allora nel congresso di Vienna per ristabilire l’ordine politico
internazionale, ripristinando i vecchi regimi assoluti. Nel 1817 in Germania le
associazioni nazionaliste danno vita a manifestazioni ispirate a ideali
liberali e patriottici che vengono duramente represse. E’ in questo clima
fortemente autoritario che matura il pessimismo radicale di Schopenhauer,
contrapposto all’ottimismo e alla fiducia del progresso del pensiero idealista.
Come detto in precedenza uno dei filosofi che possono essere
ricondotti a Schopenhauer è Freud, egli infatti definisce Schopenhauer non solo
il suo precursore ma anche il fondatore della psicoanalisi. Schopenhauer
credeva che la psiche umana non fosse altro che pulsione, sessualità quindi
l’eros e aggressività quindi l’inconscio, e l’unico aspetto che lo distingueva
da Freud è che gli mancava il materiale per riuscire a giustificare le sue
teorie. Secondo Freud la ragione è lo strumento per il dominio della natura e
degli uomini, che non vi è nulla al di fuori della realtà e che la psiche si
sviluppa in base al principio di piacere-realtà. In base al quale il piacere è
la soddisfazione immediata del desiderio e la realtà è l’accettazione incondizionata
di ciò che è, quindi la figura di rassegnazione e dolore di Schopenhauer.
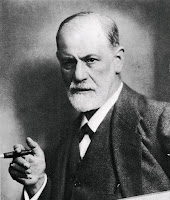
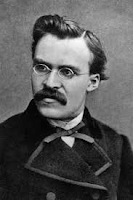

Commenti
Posta un commento