Schopenhauer e Kierkegaard
L'INDIBOLIBENTO DEL SOGGETTO
L'ESSENZA IRRAZIONALE DELL'ESSERE UMANO
I filosofi che per i primi sollevano pesanti obiezioni alla concezione edificante dell'io propria della tradizione ottocentesca sono Schopenhauer e Kierkegaard. Loro bersaglio polemico è principalmente la filosofia di Hegel, cioè una visione in cui la visione in cui l'individualità trova il suo fondamento in un principio razionale superiore, lo spirito o idea, e il soggetto è assorbito da un io assoluto che concilia in sé ogni contraddizione, ambiguità e problematicità.
Per Arthur Schopenhauer essenza dell'uomo è l'irrazionale impersonale <volontà di vivere>, l'<eterno e cieco impulso> di cui ogni cosa non è che la manifestazione fenomenica. Tale istinto spinge gli esseri umani a desiderare continuamente un appagamento che non potranno ottenere, e influisce inconsapevolmente sulle loro scelte, ambizioni e aspirazioni. Queste ultime non sono peraltro orientate da nobili ideali, ma dai bisogni, dall'esigenza primaria di autoconservazione che <ferve e vegeta> in ogni essere condannandolo all'infelicità e al dolore. Una simile visione pessimistica dell'uomo sarebbe accettabile per Michela e Leo: essi credono in un soggetto in grado di agire sulla realtà, cambiarla in nome di valori assoluti e di principii di giustizia universali. Tuttavia, potrebbero forse concordare con la prospettiva etica di Schopenhauer nel momento in cui riconduce la morale al sentimento di compassione, attraverso cui avvertiamo come nostre le sofferenze degli altri. IL loro impiego può essere visto come un atto di pietà profonda dettato dalla consapevolezza della fragilità dell'essere umano e di un destino di sofferenza comune.
L'IO COME "POSSIBILITA'" E IL SENTIMENTO DELL'ANGOSCIA
Anche Kierkegaard analizza lucidamente i limiti della soggettività individuale, la cui esistenza è caratterizzata dall'incertezza, dall'instabilità e dal dubbio. L'essere umano è infatti costantemente chiamato a "scegliere" tra infinite opzioni, scontrandosi con il rischio del male e della negatività che genera l'angoscia. A differenza della paura, che scaturisce in relazione a qualcosa di determinato, l'angoscia deriva dall'indeterminatezza del possibile, dal fatto che, in assenza di certezze assolute e di valori stabili, la decisione risulta problematica, in particolare di fronte ad alternative inconciliabili. Questa condizione rende l'io estremamente fragile. Solo la fede, cioè l'affidarsi dell'uomo a Dio, che costituisce il suo stesso fondamento, può offrire un sollievo alla disperazione; tuttavia anch'essa è priva di garanzie. Data la radicale inadeguatezza degli strumenti razionali dell'io, la fede implica infatti un <salto> al di là della ragione, una scelta "paradossale" per qualcosa che trascende la compressione umana.
L'atto di fede di Michela e Leo è di natura religiosa, eppure presenta un aspetto "paradossale": nell'incertezza e nel vuoto di valori che contraddistinguono la società contemporanea i due protagonisti, nonostante le delusioni, le smentite e le sconfitte che fanno vacillare la loro stessa identità, scelgono di "credere" ancora in alcuni principi, in relazione ai quali orientano la propria esistenza.
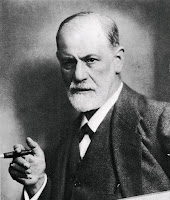
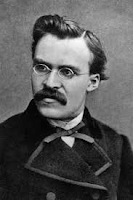

Commenti
Posta un commento